“Il ritorno di Ulisse in patria” è la prima scritta da Monteverdi per un teatro di Venezia, un’opera complessa, ricca di sfumature, in cui i personaggi, in tutte le loro sfaccettature umane, dagli dei ai nobili ai popolani, sono rappresentati dal librettista Giacomo Badoaro in perfetto connubio con Monteverdi: parole, canto e musica si uniscono per ridonarci un teatro dei sentimenti allo stato puro. E qui sta la sua grandezza: non ne possiamo intonare forse alcuni brani, come succede per “Orfeo” o soprattutto per “L’incoronazione di Poppea”, ma la musica agisce come pura, fulgente rappresentazione del personaggio, e spesso recitativo e aria si intersecano tra loro per ridonarci un teatro dei sentimenti allo stato puro.
La vicenda che vede Ulisse protagonista è preceduta, come accade sempre in Monteverdi, da un prologo in cui l’Humana Fragilità, contrapposta al Tempo, alla Fortuna e all’Amore, deplora la sua condizione mortale.
Durante i tre atti che compongono l’opera viene raccontato il ritorno di Ulisse ad Itaca dopo la guerra di Troia e le sue famose peregrinazioni sul mare.
Ne seguiamo l’arrivo ad Itaca, camuffato da vecchio mendicante, con la vendetta sui Proci dopo la famosa prova dell’arco, aiutato dal figlio Telemaco e dal fedele pastore Eumete.
L’opera si conclude con l’incontro dell’eroe greco con la moglie Penelope, che dopo i primi tentennamenti finalmente, con l’aiuto della vecchia balia Euriclea, lo riconosce.
Della partita sono anche l’ancella Melanto e il suo amante Eurimaco, e Iro il pitocco, che si contrappone a lui in una gara di lotta.
Ovviamente su ogni cosa vegliano gli Dei, spesso vendicativi, altre volte di grande generosità: Giove, Nettuno, Minerva e Giunone.
La musica agisce come pura e fulgente rappresentazione dei 19 personaggi, restituendocene sulla scena la loro intima natura, con l’intrecciare sublime di recitativi e arie.
Molti i momenti da incorniciare di questo capolavoro misconosciuto, di rara e difficile rappresentazione: il lamento iniziale di Penelope (“Di Misera Regina”, con la ripetizione di quel “Deh torna, Ulisse, torna” che entra nel cuore), l’abbraccio commovente e commosso tra Ulisse e il figlio Telemaco (“O padre sospirato, O figlio desiato), il meraviglioso lamento di Iro il pitocco, personaggio secondario che viene nobilitato da un’aria colma di melanconia nella sua apparente stoltezza (“O dolor, o martir che l’alma attrista ), il riconoscimento di Penelope con il marito (“Sospirato mio sole! Rinnovata mia luce!… Del piacer, del goder venuto è ‘l di. Sì, sì, vita, sì, sì core, sì, sì!”).
Partiamo da Luigi De Angelis del collettivo Fanny e Alexander, il cui cammino artistico seguiamo sin dai suoi inizi e che ultimamente ci ha entusiasmato con la sua regia de La Trilogia della Città di K. Di Agota Kristof e che aveva già incontrato Monteverdi, catapultando efficacemente Orfeo in una metropolitana. Qua ne “Il ritorno di Ulisse in patria” (con i bei costumi e la drammaturgia dell'inseparabile Chiara Lagani) sceglie di iniziare il suo allestimento con il video di Ulisse disteso come lo hanno lasciato i Feaci. Itaca sul palco, è un luogo idilliaco popolato da sagome di alberi e animali, governato dal fedele Eumete. La rappresentazione è volutamente Pop : I Proci sono dei fannulloni che, per passare il tempo, si dedicano alla Play Station. Penelope è invece una donna elegantissima che abita solitaria su una poltrona vivendo la sua solitudine. Ad un certo punto a farla da padrone ecco un bellissimo arco dorato, vero risolutore della storia. Tutti i personaggi, tra passato e presente, sono sempre ben caratterizzati, con gli Dei luccicanti che si muovono in uno spazio che le luci rendono etereo.
Tutto viene raccontato in modo assolutamente scevro da ogni possibile barocchismo, con pochissimi segni che definiscono in modo preciso personaggi e situazioni. Ecco quindi il telaio, il letto nuziale, il trono di bianca e semplice geometria per Penelope, il fulmine che caratterizza Giove con l’evidenza del suo fisico possente, accompagnato da un vero meraviglioso falcone, il tridente per Nettuno, l’elmo per una Minerva di bianco vestita, un bastone per il mendicante, un grande arco che inutilmente i tre Proci cercano di utilizzare.
Tutto è espresso attraverso una eleganza formale di autentica meraviglia nella sua estrema semplicità di accenti.
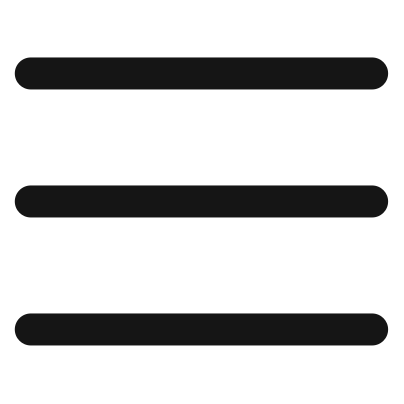


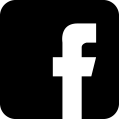
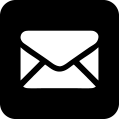
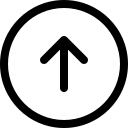

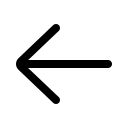 Torna indietro
Torna indietro